Caraffe e bottiglie
La rivoluzione arrivò con le bottiglie, fu il grande contributo del diciassettesimo secolo alla storia del vino.
Fonte: HUGH JOHNSON – Il Vino – Franco Muzzio Editore 1991
Fino all’arrivo dei sofisticatori olandesi con la loro acquavite e le loro diavolerie con lo zolfo, la prima preoccupazione di ogni mercante di vino era liberarsi della sua merce al più presto possibile. Si trattava di giocare, letteralmente, a scaricabarile. Un barile di vino era merce deperibile, con uria data di scadenza che si avvicinava sempre di più.
 Con poche eccezioni, come i mercanti di Venezia che commerciavano in vini molto alcolici, o i principi-vescovi del Reno, che potevano disporre di cantine fredde e di botti gigantesche, il primo principio di chiunque commerciasse in vino era di consegnarlo subito a un cliente. La parte del mercante era semplicemente quella di un trasportatore, che caricava il prodotto nella zona di origine e lo distribuiva appena arrivato in porto. Ciò che i Francesi chiamano élevage del vino – il suo “allevamento” in cantine dove viene conservato con cura e a volte tagliato – praticamente non esisteva. E se il prodotto non si conservava, non aveva neppure bisogno di una complicati organizzazione commerciale. Nella Francia del Medioevo i mercanti di aceto erano meglio organizzati dei mercanti di vino: il loro prodotto si poteva immagazzinare, miscelare, e distribuire a seconda della domanda.
Con poche eccezioni, come i mercanti di Venezia che commerciavano in vini molto alcolici, o i principi-vescovi del Reno, che potevano disporre di cantine fredde e di botti gigantesche, il primo principio di chiunque commerciasse in vino era di consegnarlo subito a un cliente. La parte del mercante era semplicemente quella di un trasportatore, che caricava il prodotto nella zona di origine e lo distribuiva appena arrivato in porto. Ciò che i Francesi chiamano élevage del vino – il suo “allevamento” in cantine dove viene conservato con cura e a volte tagliato – praticamente non esisteva. E se il prodotto non si conservava, non aveva neppure bisogno di una complicati organizzazione commerciale. Nella Francia del Medioevo i mercanti di aceto erano meglio organizzati dei mercanti di vino: il loro prodotto si poteva immagazzinare, miscelare, e distribuire a seconda della domanda.
Perché il vino si trasformava tanto rapidamente in aceto? Perché molti dei batteri che contiene, e in particolare quello chiamato Acetobeter aceti, sono capaci di moltiplicarsi disastrosamente in presenza di ossigeno. Il risultato di questa moltiplicazione è l’acido acetico, cioè l’aceto. Come in tutte le reazioni biochimiche, il processo è tanto più lento quanto più bassa è la temperatura: ecco il vantaggio delle cantine della Renania. Il vantaggio delle botti gigantesche era semplicemente il fatto che un maggior volume di liquido presenta una superficie in proporzione più piccola, e quindi offre meno possibilità di contatto fra l’Acetobacter e il vino di cui si nutre.
Anche un alto contenuto di alcol svolge un’azione protettiva: sotto l’influenza dell’alcol l’attività riproduttiva dei batteri è rallentata. L’anidride solforosa fa lo stesso effetto. Le ragioni scientifiche erano sconosciute, ma agli Olandesi bastava la conoscenza empirica dei fatti quando bruciavano il loro zolfo e aggiungevano il loro brandewijn. In ogni caso però trattavano ancora il vino in grandi quantitativi, vendendolo a barili, e senza saperlo lo esponevano a tutti i rischi di contatto con l’aria. Invece i Tedeschi, sempre agendo empiricamente, avevano trovato un metodo migliore nelle loro cantine: si assicuravano che i loro serbatoi (perché per simili mostri non si può usare il nome di botti) fossero sempre pieni fino all’orlo. Ogni volta che spillavano del vino, li rabboccavano immediatamente, attingendo a barili più piccoli di vino dello stesso tipo. Se non avevano nulla di adatto, arrivavano a mettere nella botte delle pietre (ben lavate nel vino), per far salire il livello del liquido ed espellere quanta più aria possibile.
La rivoluzione arrivò con le bottiglie, e con la scoperta di un modo sicuro per chiuderle ermeticamente. Questo fu il grande contributo del diciassettesimo secolo alla storia del vino: le bottiglie e i tappi. Senza di esse, sarebbe stato ancora possibile migliorare la qualità del vino, ma non la sua capacità di invecchiare.

Dai tempi dei Romani, nessuno più aveva saputo quali trasformazioni possano avvenire quando un buon vino è tenuto per molto tempo fuori del contatto dell’aria. Non si tratta solo di un sapore più piacevole o più morbido, ma di un’intera nuova dimensione del sapore. Per spiegare questo fortunatissimo fenomeno, dobbiamo chiedere un piccolo aiuto alla scienza.
Quando il vino si trova in una bottiglia ben tappata non ha più contatti con l’aria, e l’aria non ne ha con il vino. La bottiglia contiene una piccola quantità di ossigeno, nonché di anidride carbonica. Entrambi i gas sono solubili, sono presenti al momento dell’imbottigliamento, e quindi entrano nella bottiglia insieme al vino.
Ma da quel momento in poi la loro quantità rimane fissa. Il vino può essere pieno di microbi e batteri: ma poiché: hanno bisogno di ossigeno per riprodursi, la loro capacità di riproduzione è limitata dal piccolissimo quantitativo di ossigeno presente nella bottiglia. Tutti i processi vitali degli organismi che determinano il sapore e l’aroma del vino sono rallentati al massimo in una bottiglia tappata, tanto più se la bottiglia è tenuta in un ambiente fresco.
Vi sono altre reazioni biochimiche a contendersi il poco ossigeno disponibile. I pigmenti, i tannini, gli acidi e centinaia di altri composti organici sono naturalmente instabili, e continuano a combinarsi e a ricombinarsi formando nuovi composti. Alcune reazioni sono anaerobiche, ossia avvengono in assenza di aria. La maggior parte, però, ha bisogno di ossigeno per rimaneggiare le varie strutture chimiche. Perciò il vino nella bottiglia si trova in uno stato “riduttivo”: ogni trasformazione riduce la possibilità di altre trasformazioni consumando l’ossigeno presente.
In queste circostanze gli equilibri sono estremamente delicati. È necessario che il vino abbia le giuste qualità: per esempio, un buon equilibrio fra i componenti acidi, i tannini e lo zucchero (gli ingredienti naturali identificati nel vino sono più vicini a cinquecento che a quattrocento). Ma grazie a questa struttura intrinseca del vino, il gioco degli equilibri può meritare l’appellativo più felice di “sinfonia chimica”.
 Di tutto questo, i fabbricanti di bottiglie del Cinquecento non avevano nemmeno l’idea. Le bottiglie servivano solo a portare il vino dalla botte alla tavola. Ce n’erano di tutti i tipi quanto a robustezza ed eleganza: da rozzi recipienti di cuoio a caraffe di ceramica, fino a bellissime fiasche di vetro trasparente. Il vetro, uno dei materiali più costosi, era anche il più fragile. Il suo valore come “status symbol” fu messo in evidenza da William Harrison nella sua Description of England (Descrizione dell’Inghilterra) del 1586: “È straordinario vedere in questi nostri giorni nei quali abbondano l’oro e l’argento, come la nostra nobiltà, disprezzando questi metalli (per causa dell’abbondanza) ora generalmente sceglie piuttosto i vetri di Venezia … “.
Di tutto questo, i fabbricanti di bottiglie del Cinquecento non avevano nemmeno l’idea. Le bottiglie servivano solo a portare il vino dalla botte alla tavola. Ce n’erano di tutti i tipi quanto a robustezza ed eleganza: da rozzi recipienti di cuoio a caraffe di ceramica, fino a bellissime fiasche di vetro trasparente. Il vetro, uno dei materiali più costosi, era anche il più fragile. Il suo valore come “status symbol” fu messo in evidenza da William Harrison nella sua Description of England (Descrizione dell’Inghilterra) del 1586: “È straordinario vedere in questi nostri giorni nei quali abbondano l’oro e l’argento, come la nostra nobiltà, disprezzando questi metalli (per causa dell’abbondanza) ora generalmente sceglie piuttosto i vetri di Venezia … “.
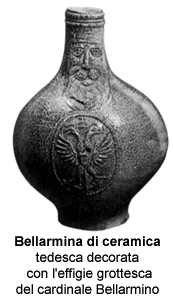 Per chi non poteva permettersi il vetro, il surrogato più comune era un tipo di ceramica vetrificata originaria della Renania. Veniva vetrificata gettando nel forno manciate di sale da cucina durante la cottura. Il sale reagiva con i minerali dell’argilla producendo una superficie vetrosa, screziata, generalmente grigia o bruna. Per molto tempo tutte le bottiglie fabbricate in questo modo ebbero la stessa forma panciuta, e furono decorate con una maschera grottesca sotto l’imboccatura. Questo brutto ceffo rappresentava il cardinale italiano Roberto Bellarmino [Lo stesso che fece condannare Galileo], particolarmente odiato per la sua intransigenza nell’avversare il protestantesimo. Da lui queste bottiglie presero il nome di bellarmine.
Per chi non poteva permettersi il vetro, il surrogato più comune era un tipo di ceramica vetrificata originaria della Renania. Veniva vetrificata gettando nel forno manciate di sale da cucina durante la cottura. Il sale reagiva con i minerali dell’argilla producendo una superficie vetrosa, screziata, generalmente grigia o bruna. Per molto tempo tutte le bottiglie fabbricate in questo modo ebbero la stessa forma panciuta, e furono decorate con una maschera grottesca sotto l’imboccatura. Questo brutto ceffo rappresentava il cardinale italiano Roberto Bellarmino [Lo stesso che fece condannare Galileo], particolarmente odiato per la sua intransigenza nell’avversare il protestantesimo. Da lui queste bottiglie presero il nome di bellarmine.
Per rimediare alla fragilità delle bottiglie di vetro fatte alla maniera italiana (quando la tecnologia del vetro veniva soprattutto dall’Italia) si pensò di rivestirle di paglia (o di vimini, o di pelle). Il conosciutissimo fiasco toscano nacque nel Trecento o nel Quattrocento. Un tipo più complicato, detto “cantinflora” o “cantimplora”, aveva il collo ricurvo e una tasca sul fianco, destinata a contenere il ghiaccio usato per raffreddare il vino. Le Fiandre, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi erano grandi produttori di vetro. Gli Olandesi ebbero l’idea molto pratica di soffiare le bottiglie in stampi a sezione quadrata, per poterle imballare in cassette senza sprecare spazio. La forma quadrata sopravvive nelle bottiglie di gin olandese: non si sa perché sia stata abbandonata per le bottiglie da vino. Ma dal momento che ben poche di queste bottiglie del diciassettesimo secolo sono giunte fino a noi, si può pensare che fossero molto fragili.
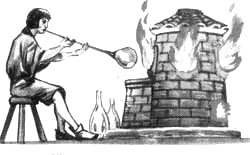 Le bottiglie più ordinarie erano fatte di peltro, o addirittura di legno, con lo svantaggio che non si poteva mai vedere se fossero ben pulite. Ma finché tutto il vetro veniva soffiato, e quindi era sottile, non poteva che restare un articolo di lusso. Infatti non esistevano fabbriche specializzate nel produrre bottiglie: le bottiglie uscivano dalle stesse fabbriche che facevano i bicchieri e i vetri per le finestre. Nonostante ciò, nell’Inghilterra del Seicento la richiesta di bottiglie aumentò a tal punto (malgrado un’ondata di importazioni di bellarmine dalla Renania), da preoccupare la Corona, perché i boschi venivano distrutti per procurare legna da ardere alle innumerevoli fornaci. Il risultato fu un proclama di re Giacomo I:
Le bottiglie più ordinarie erano fatte di peltro, o addirittura di legno, con lo svantaggio che non si poteva mai vedere se fossero ben pulite. Ma finché tutto il vetro veniva soffiato, e quindi era sottile, non poteva che restare un articolo di lusso. Infatti non esistevano fabbriche specializzate nel produrre bottiglie: le bottiglie uscivano dalle stesse fabbriche che facevano i bicchieri e i vetri per le finestre. Nonostante ciò, nell’Inghilterra del Seicento la richiesta di bottiglie aumentò a tal punto (malgrado un’ondata di importazioni di bellarmine dalla Renania), da preoccupare la Corona, perché i boschi venivano distrutti per procurare legna da ardere alle innumerevoli fornaci. Il risultato fu un proclama di re Giacomo I:
“acciocché questioni di superfluità non divorino materiali di necessità e di difesa; preso atto che in anni recenti lo spreco di legna e di legname è stato eccessivo e intollerabile da parte delle vetrerie [… ] considerato che sia un male minore far retrocedere i tempi alle antiche usanze di bere dalla ceramica e delle finestre a piombo, piuttosto che subire la perdita di un così grande tesoro [. . . ] Perciò noi [. . . ] ordiniamo direttamente che […] nessuno […] potrà fondere, fabbricare o fare fondere o fabbricare alcun […] vetro di qualsiasi tipo con legna o legname, in questo nostro Regno […]”.
Così, finché le vetrerie non cambiavano combustibile, si doveva tornare alle caraffe di ceramica e alle finestre fatte con piccoli pezzi di vetro legati a piombo. A quei tempi il re offriva monopoli ai fabbricanti, naturalmente a caro prezzo. Il monopolio della fabbricazione del vetro con forni a carbone fu comprato da sir Robert Mansell, che negli anni venti del seicento andò a stabilirsi nei pressi delle miniere di carbone più famose dell’Inghilterra, quelle di Newcastle-upon-Tyne nel nord-est del paese. Egli però ottenne il permesso di subaffittare il suo monopolio ad altri, di conseguenza vi fu una proliferazione di vetrerie con forni a carbone in varie parti dell’Inghilterra. Si scoprì che con il carbone si potevano ottenere temperature più alte che permettevano di produrre vetri più robusti, anche se non così bianchi come quelli di stile veneziano.
A questo punto, la storia della bottiglia, come tutto il resto in Inghilterra, si confonde con le vicissitudini della casa reale degli Stuart, culminate nella guerra civile del 1642-49; ma tutti i dati disponibili indicano che il nuovo tipo di bottiglia che sostituì quelle di Mansell (ancora relativamente fragili) fu inventato da quella straordinaria figura di cortigiano, scrittore, alchimista e perfino pirata a tempo perso, che fu sir Kenelm Digby. Poco dopo il 1630, forse a Newnham-on-Severn nel Gloucestershire vicino alle miniere di carbone della foresta di Dean, Digby cominciò a fabbricare delle bottiglie molto più spesse, più pesanti, più robuste e più scure, oltre che meno costose, di qualunque altra bottiglia conosciuta a quei tempi.
 Avevano una forma tondeggiante, a bolla, con un lungo collo che si restringeva verso l’alto e terminava con un “colletto” che serviva a trattenere la cordicella a cui era legato il tappo. Il fondo aveva una profonda rientranza lasciata dalla canna del soffiatore, cosa che le rendeva molto stabili in posizione verticale. A quanto sembra Digby aveva trovato il modo di rendere il suo forno ancora più caldo usando un sistema di ventilazione forzata, per poter fondere una miscela contenente più sabbia e meno potassa e calce. I fumi del carbone davano alla pasta un colore bruno o verde scuro, ma questo era considerato un segno di robustezza (e avrebbe avuto il vantaggio imprevisto di proteggere il vino dalla luce). Dopo qual che tempo Digby finì in carcere perché monarchico e cattolico, e altri si attribuirono la paternità del suo processo di lavorazione; ma nel 1662 il parlamento riconobbe che l’inventore era lui. Fu lui il padre della bottiglia da vino moderna. La sua tecnica venne adottata in Olanda solo verso il 1670; in Francia addirittura nel 1709 (e le bottiglie furono definite “all’inglese”).
Avevano una forma tondeggiante, a bolla, con un lungo collo che si restringeva verso l’alto e terminava con un “colletto” che serviva a trattenere la cordicella a cui era legato il tappo. Il fondo aveva una profonda rientranza lasciata dalla canna del soffiatore, cosa che le rendeva molto stabili in posizione verticale. A quanto sembra Digby aveva trovato il modo di rendere il suo forno ancora più caldo usando un sistema di ventilazione forzata, per poter fondere una miscela contenente più sabbia e meno potassa e calce. I fumi del carbone davano alla pasta un colore bruno o verde scuro, ma questo era considerato un segno di robustezza (e avrebbe avuto il vantaggio imprevisto di proteggere il vino dalla luce). Dopo qual che tempo Digby finì in carcere perché monarchico e cattolico, e altri si attribuirono la paternità del suo processo di lavorazione; ma nel 1662 il parlamento riconobbe che l’inventore era lui. Fu lui il padre della bottiglia da vino moderna. La sua tecnica venne adottata in Olanda solo verso il 1670; in Francia addirittura nel 1709 (e le bottiglie furono definite “all’inglese”).
Ora non rimaneva che trovare il tappo perfetto. Qualunque fosse il tipo di bottiglia, quello del tappo era un problema annoso. Il sughero, sebbene già usato dai Romani, era stato dimenticato. Nei dipinti medievali si vedono panni attorcigliati e usati come tappi, oppure stesi sull’imboccatura della bottiglia e assicurati con un pezzo di corda. Si usava anche la pelle, a volta coperta di ceralacca. I tappi di sughero vengono nominati a partire dalla metà del sedicesimo secolo. Quando Shakespeare scrisse Come vi pare (fra il 1598 e il 1600) erano già abbastanza diffusi, perché Rosalinda potesse dire: “Di grazia togli il tappo dalla tua bocca, ché io possa bere le tue notizie”. [Shakespeare usa la parola cork, che significa “tappo” ma anche “sughero”].
 E stato, e potrebbe essere vero, che l’uso del sughero si diffuse grazie alle migliaia di pellegrini che viaggiavano a piedi nel nord della Spagna diretti a Santiago de Compostela. Male querce da sughero crescono nel sud (e non nel nord) della Spagna e del Portogallo, e il sud comunicava direttamente via mare con il resto dell’Europa, pertanto è più probabile che il sughero sia arrivato in Europa dal sud (sempre che fosse usato in quelle regioni).
E stato, e potrebbe essere vero, che l’uso del sughero si diffuse grazie alle migliaia di pellegrini che viaggiavano a piedi nel nord della Spagna diretti a Santiago de Compostela. Male querce da sughero crescono nel sud (e non nel nord) della Spagna e del Portogallo, e il sud comunicava direttamente via mare con il resto dell’Europa, pertanto è più probabile che il sughero sia arrivato in Europa dal sud (sempre che fosse usato in quelle regioni).
Sembra che il matrimonio fra il sughero e la bottiglia sia avvenuto per gradi, almeno in Inghilterra, nella prima metà del diciassettesimo secolo. Digby, che era uno sperimentatore inveterato, non si lasciò convincere del tutto. Nel suo libro The Closet Opened (Il gabinetto rivelato), elenca ogni sorta di ricette per l’idromele (una bevanda fortemente alcolica ottenuta dalla fermentazione del miele). A volte consiglia tappi di sughero, a volte di vetro smerigliato. A un certo punto sembra che abbia provato a produrre un methegelin (cioè un tipo di idromele) bianco spumante, perché la sua ricetta si chiude così: “Se volete berlo entro poco tempo, mettetelo nelle bottiglie, e strofinate i tappi [di sughero] con lievito in modo che tocchi il methegelin, e in tre o quattro giorni sarà pronto per essere bevuto” – o per esplodere, vien fatto di pensare, dato che il lievito dava inizio a una nuova fermentazione nella bottiglia.
I tappi di vetro smerigliato fatti su misura per il collo della bottiglia rimasero in uso per molto tempo. Dal Treatise of Cider (Trattato sul sidro) di Worlidge, pubblicato nel 1676, è chiaro che era necessario scegliere i tappi di sughero con molta attenzione, perché “molto vino viene assolutamente rovinato  unicamente a causa dei difetti del sughero. Perciò si devono preferire i tappi di vetro […]”, anche a costo di difficoltà non indifferenti, dato che ciascun tappo doveva essere molato (usando olio e smeriglio in polvere) per infilarsi esattamente in una data bottiglia. Il tappo era sormontato da un pomolo che serviva per legarlo alla bottiglia con un pezzo di spago, perché naturalmente andava bene solo per la bottiglia per cui era stato fatto. Bellissime bottiglie fatte a mano e bouchée a l’èmeri (cioè con tappi di vetro smerigliato) furono usate per alcuni dei vini di Château Lafite, nel 1820 e nel 1825. Si credeva (erroneamente) che il sughero permettesse all’aria di raggiungere e danneggiare il vino: in realtà, i problema era probabilmente causato da sugheri di qualità inferiore, che davano al vino un sapore “di tappo”. Alla fine, i tappi di vetro furono abbandonati perché il più delle volte era impossibile toglierli senza rompere la bottiglia.
unicamente a causa dei difetti del sughero. Perciò si devono preferire i tappi di vetro […]”, anche a costo di difficoltà non indifferenti, dato che ciascun tappo doveva essere molato (usando olio e smeriglio in polvere) per infilarsi esattamente in una data bottiglia. Il tappo era sormontato da un pomolo che serviva per legarlo alla bottiglia con un pezzo di spago, perché naturalmente andava bene solo per la bottiglia per cui era stato fatto. Bellissime bottiglie fatte a mano e bouchée a l’èmeri (cioè con tappi di vetro smerigliato) furono usate per alcuni dei vini di Château Lafite, nel 1820 e nel 1825. Si credeva (erroneamente) che il sughero permettesse all’aria di raggiungere e danneggiare il vino: in realtà, i problema era probabilmente causato da sugheri di qualità inferiore, che davano al vino un sapore “di tappo”. Alla fine, i tappi di vetro furono abbandonati perché il più delle volte era impossibile toglierli senza rompere la bottiglia.
Nel Seicento, le uniche bevande imbottigliate in casa nel nord Europa erano il sidro, la birra e i vini fatti in casa. I mercanti di vino cominciarono a imbottigliare solo negli ultimi anni del secolo. Nel 1609, il libro Delights for Ladies (Delizie per le signore) di sir Hugh Plat consigliava di lasciare la birra nel barile per dieci o dodici giorni prima di imbottigliarla (probabilmente in bottiglie di ceramica), “usando tappi della giusta misura per le bottiglie e spingendoveli dentro in modo che siano ben stretti.” Aggiungeva poi che “la ragione per cui la birra in bottiglia è al tempo stesso spumosa e torbida, ed esplode e fuma quando si apre”, è che di solito veniva imbottigliata troppo presto, mentre conteneva ancora lievito in via di fermentazione. Nel 1676, quando Worlidge scrisse il suo trattato sul sidro, esistevano già tutte le premesse per un imbottigliamento di tipo moderno. Avendo scelto dei buoni tappi di sughero, scrive Worlidge, metteteli a bagno in acqua bollente “ed essi si adatteranno meglio alla bocca della bottiglia che se vi fossero forzati ancora asciutti; inoltre l’umidità del tappo gli permette di trattenere meglio lo spirito”.
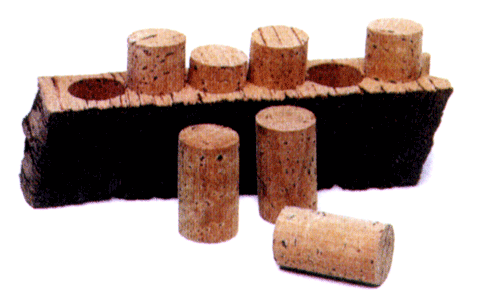
“Perciò”, continua, “s’ha da consigliare di coricare la bottiglia sul suo fianco, non solo per conservare umido il tappo, ma acciò che l’aria rimanente nella bottiglia si trovi sul fianco della bottiglia donde non può espirare” (cioè sfuggire), “né può nuova aria essere introdotta, perché il liquore è contro il tappo. Alcuni pongono le bottiglie sopra un traliccio con il naso in basso per questo scopo”, ma non è una buona idea, dice Worlidge, perché (come sa chiunque abbia visitato la cantina di un produttore di champagne) tutto il sedimento del vino si accumula sul tappo, e “voi sarete sicuri di averlo nel primo bicchiere”. La sua cantina ideale deve avere “una sorgente fredda e rinfrescante” che manterrà il sidro “finché sia giunto a una forza pari anche a quella dello stesso Canary.” Esistono ancora cantine del diciassettesimo secolo con scafali pieni di buchi per accogliere i “nasi” delle bottiglie capovolte. Altri usavano per lo stesso scopo un letto di sabbia. Quello che è certo è che il principio della maturazione dei vini in bottiglie tappate era ormai noto a tutti.
Non restava che inventare due cose: il cavatappi, per potere spingere il tappo fino in fondo invece di lasciarlo fuori a metà, e le bottiglie cilindriche, per poterle conservare coricate e non con la testa nella sabbia come gli struzzi. Le seconde furono perfezionate gradualmente nella prima metà del diciottesimo secolo, ma il primo rimane un mistero insoluto.
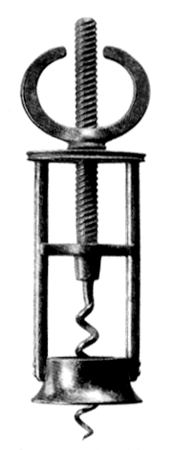 La prima menzione scritta di un cavatappi compare molto più tardi di quanto ci si possa immaginare, cioè nel 1681. Era definito (da un certo N. Grew) come “una vite di acciaio usata per tirare i tappi fuori dalle bottiglie”. Le “viti di acciaio” erano in uso da almeno cinquant’anni per estrarre le pallottole e gli stoppacci dalle armi da fuoco che avevano fatto cilecca (un’operazione da far tremare le gambe). Quando fu che la sete spinse l’immaginazione a fare il collegamento con le bottiglie? Nessuno lo sa.
La prima menzione scritta di un cavatappi compare molto più tardi di quanto ci si possa immaginare, cioè nel 1681. Era definito (da un certo N. Grew) come “una vite di acciaio usata per tirare i tappi fuori dalle bottiglie”. Le “viti di acciaio” erano in uso da almeno cinquant’anni per estrarre le pallottole e gli stoppacci dalle armi da fuoco che avevano fatto cilecca (un’operazione da far tremare le gambe). Quando fu che la sete spinse l’immaginazione a fare il collegamento con le bottiglie? Nessuno lo sa.
La prima descrizione scritta di un cavatappi è forse quella pubblicata nel 1700 in The London Spy (L’osservatore di Londra), un curioso libro sugli usi e costumi di Londra scritto da un tale Ned Ward, taverniere e convinto ammiratore del claret e dei Tories (i conservatori di allora). Il libro è scritto in prima persona da un immaginario uomo di campagna che viene accompagnato da un amico cockney a vedere le meraviglie di Londra. I due si godono i divertimenti della città a tutti i livelli (alcuni dei quali sono riccamente indecorosi). In questa occasione viene descritta una cena in compagnia di due parroci anglicani di campagna e di un quacchero. È evidente che il cavatappi era già un oggetto di uso comune:
Alla fine arrivammo a una bella […] bottiglia di claret, che conteneva almeno mezza pinta più del normale, ma il tappo era cacciato dentro così bene che non c’era modo di toglierlo senza un cavatappi. Provarono in parecchi a smuovere con i pollici quell’ostacolo così ostinato, ma nessuno riuscì nella difficile impresa; finché il padron di casa disse “Possibile che in mezzo a degli ubriaconi come noi non ci sia nessuno così previdente da avere in tasca un cavatappi?”. Il più vecchio e più saggio dei due parroci, che aveva notato le generose dimensioni della bottiglia e sapeva per esperienza che quando una bottiglia è ben tappata il vino è sempre buono, rispose: “Credo di avere io in tasca un piccolo strumento che potrebbe fare al caso nostro”, e cominciò a frugarsi nelle tasche, tirando fuori un breviario, una vecchia custodia da pettine piena di note, una grattugia per noce moscata da due penny, e fece una gran mostra di altre cose dello stesso genere, finché alla fine arrivò al sodo e tirò fuori un cavatappi, fra le risate irrefrenabili di tutti.
“Io credo, amico”, disse il quacchero, “che un breviario e un cavatappi non siano buoni compagni, e che non dovrebbero stare insieme nella stessa tasca. Perché non fai in modo che le tue brache abbiano compartimenti separati per queste cose?”. Al che rispose il parroco: “Dacché la devozione dà conforto all’anima, e il vino bevuto con moderazione conserva la salute del corpo, perché non tenere un libro che istruisce nella prima e uno strumento che permette di accedere al secondo, accompagnati l’uno all’altro così come l’anima è accompagnata al corpo?”.

